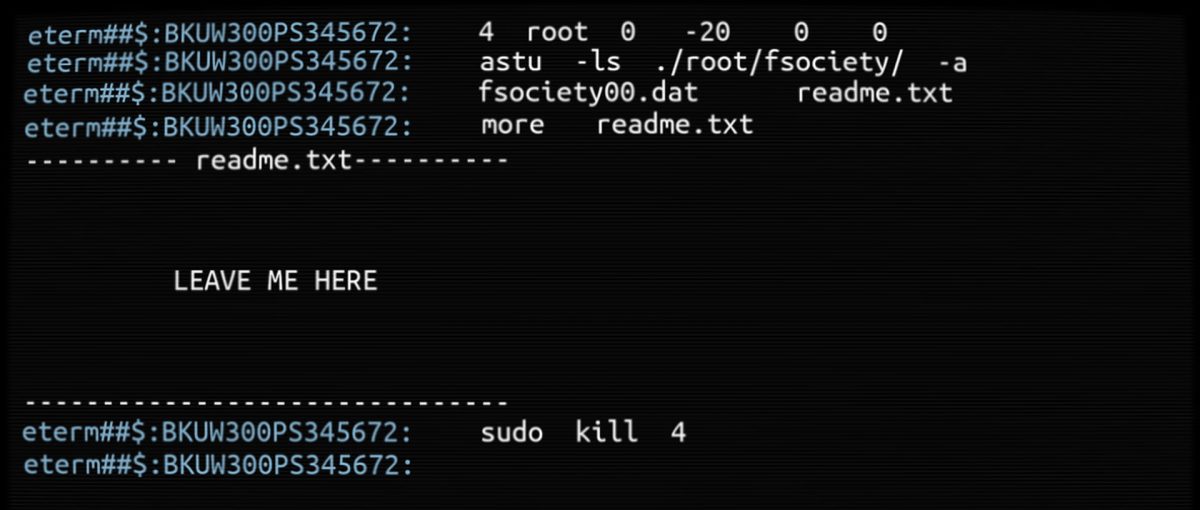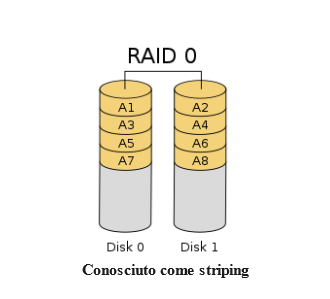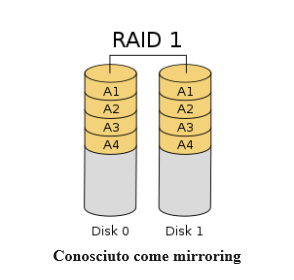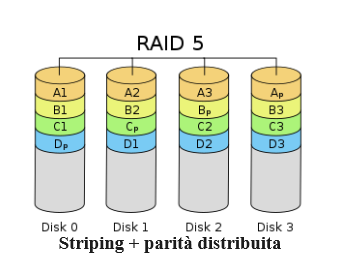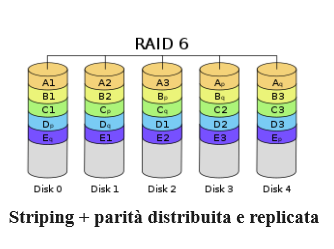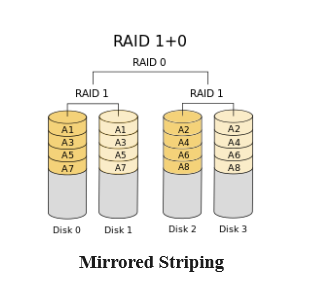Prototipazione rapida guidata dall’AI per la costruzione di MVP
Abstract
Il vibe coding descrive un paradigma di sviluppo software in cui la costruzione del prodotto avviene principalmente tramite dialogo con un modello di AI: lo sviluppatore definisce obiettivi e vincoli in linguaggio naturale, mentre l’AI genera interfacce, logica applicativa e integrazioni che vengono poi rifinite con iterazioni rapide. In questo quadro, piattaforme come Lovable e Replit riducono drasticamente il tempo tra idea e prototipo funzionante, rendendo possibile realizzare MVP pronti alla validazione in pochi giorni (o ore). Quest’articolo propone un workflow end-to-end che unisce product thinking, rapid prototyping e AI-driven development, discutendo strumenti, errori comuni, aspetti di sicurezza e una metodologia sperimentale per valutare l’efficacia del processo.
1. Introduzione e contesto
Nel ciclo di sviluppo tradizionale, l’attrito tra definizione requisiti, design, implementazione, QA e deploy introduce tempi lunghi e costi elevati. Quando l’obiettivo è validare un’ipotesi di prodotto, questo ritardo aumenta il rischio di costruire funzionalità non necessarie o di arrivare sul mercato con un’idea già superata. L’AI-driven product creation nasce come risposta a questo problema: comprimere il ciclo di feedback e trasformare rapidamente un’idea in un artefatto testabile (prototipo o MVP – Minimum Viable Product). Nell’AI-Driven Product Creation il flusso viene sintetizzato come intenzione, generazione, iterazione e rilascio dell’MVP, evidenziando il vantaggio competitivo del feedback loop rapido (Sgarbi, 2025).
2. Cos’è il Vibe Coding
Il vibe coding è una recente tecnica di programmazione assistita dall’AI in cui il programmatore descrive cosa vuole ottenere in linguaggio naturale, delegando a un agente AI (tipicamente un modello linguistico di grandi dimensioni) il compito di generare il codice sorgente. In pratica poche frasi di istruzioni (prompt) rivolte a un chatbot evoluto sostituiscono la stesura manuale del codice: lo sviluppatore passa così dal ruolo di codificare a quello di guidare, verificare e rifinire il codice prodotto dall’AI. Questo approccio, introdotto nel 2025 dal ricercatore Andrej Karpathy, punta a “dimenticarsi del codice e abbracciare le vibrazioni” per citare le parole stesse di Karpathy, cioè concentrarsi sull’idea e l’esperienza dell’applicazione lasciando all’AI la traduzione dell’intenzione in codice. I sostenitori del vibe coding evidenziano come questo permetta anche a programmatori alle prime armi di realizzare software funzionante senza dover padroneggiare tutti i dettagli tecnici tradizionali. I critici invece mettono in guardia sui rischi in termini di qualità, sicurezza e mantenibilità del codice generato interamente dall’AI senza una piena comprensione umana.
Il vibe coding può essere definito come un modo di sviluppare ‘parlando‘ con l’AI invece di scrivere codice riga per riga. L’utente descrive cosa vuole ottenere (la ‘vibe’): l’AI genera layout, logica e integrazioni; il costruttore testa, corregge e itera velocemente fino ad arrivare a un prototipo solido. Questo approccio è particolarmente efficace per prototipi, MVP e sperimentazione rapida. È però fondamentale distinguere tra accelerazione dell’execution e sostituzione del pensiero: l’AI non deve rimpiazzare l’analisi dei requisiti, la strategia di prodotto o le scelte architetturali.
3. Piattaforme per vibe coding e rapid delivery
3.1 Lovable
Lovable (lovable.dev) è una piattaforma emergente, nata dall’evoluzione del progetto open-source GPT-Engineer, che consente di costruire applicazioni web complete tramite AI. In breve, “Lovable è un agente AI che può programmare interi progetti semplicemente facendo descrivere all’utente cosa vuole”. L’esperienza d’uso tipica in Lovable inizia con la creazione di un nuovo progetto e l’apertura di una chat (simile a ChatGPT) dove l’utente fornisce un prompt dettagliato sul tipo di applicazione da creare. Ad esempio, si potrebbe chiedere “Costruisci un’app di gestione note personale con una pagina di login, una dashboard per creare/visualizzare note testuali, e salvataggio su database. Interfaccia semplice con React.”. Sulla base di questa descrizione, Lovable genera automaticamente il codice di un’app web completa: tipicamente front-end React per l’interfaccia, e un back-end basato su Supabase (un servizio BaaS che funge da database e autenticazione).
Il punto di forza di Lovable è che produce subito un progetto eseguibile e multi-componente: non pezzi di codice isolati, ma un’app funzionante con frontend, backend e database integrati. L’utente può eseguire l’app in cloud e vedere il risultato, intervenendo via chat per chiedere modifiche o nuove feature. Ad esempio, “aggiungi un campo di ricerca nelle note” potrebbe far rigenerare parte del codice per includere questa funzione. Lovable mette a disposizione anche un editor di codice nel browser, per chi volesse eventualmente rivedere o aggiustare manualmente parti del progetto. Inoltre supporta integrazioni esterne (ad esempio collegare API esterne, Google Sheets, servizi email) attraverso moduli predefiniti e prompt in linguaggio naturale. In sostanza è un ambiente no-code potenziato dall’AI, dove la logica dell’app e le condizioni vengono definite in linguaggio naturale anziché in linguaggi tradizionali.
Limiti di Lovable: come emerso da varie esperienze, Lovable dà il meglio su app semplici o MVP e incontra difficoltà man mano che la complessità cresce. Utenti avanzati riportano che tentando di implementare logiche molto articolate o integrazioni non standard, l’AI può entrare in loop di errori e correzioni fallite, consumando crediti senza risolvere il problema. Ad esempio, in un progetto con molte API esterne e logiche condizionali, Lovable poteva introdurre bug difficili da eliminare e spesso asseriva di averli risolti quando non era così. Chi non ha competenze di programmazione potrebbe trovarsi bloccato in questi casi, dovendo pagare ulteriori prompt all’AI senza vedere progressi. Un consiglio dagli utenti più esperti è di spezzare le richieste in sotto-task e mantenere i prompt molto chiari e specifici, in modo da guidare l’AI gradualmente. Lovable è comunque in rapida evoluzione: rispetto ai primi mesi di lancio (2024), gli algoritmi sono migliorati riducendo errori di compilazione e comportamenti allucinatori. Inoltre, imparare a scrivere prompt “difensivi” e a sfruttare strumenti di debug (Lovable fornisce indicatori di salute del sistema, log, ecc.) aiuta a superare molti intoppi. Va ricordato però che Lovable per ora tende a vincolare il progetto a un certo stack tecnologico (React/Supabase) e può non essere adatto a prodotti finali complessi destinati alla produzione senza un passaggio successivo di refactoring manuale. In altre parole, è eccellente per prototipi e mockup rapidi, che poi all’occorrenza possono essere rifiniti fuori dalla piattaforma per raggiungere la qualità di produzione.
Lovable è una piattaforma orientata al ‘chat-to-app’: tramite prompt in linguaggio naturale è possibile generare rapidamente un’applicazione con frontend, logica e integrazioni (ad esempio Supabase), con un deploy estremamente rapido. Viene descritta come ottimizzata per velocità estrema, con generazione full-stack e pubblicazione con URL live in pochi secondi (Sgarbi, 2025). Il suo punto di forza è la conversione immediata di requisiti in un artefatto provabile, utile per demo e validazione.
3.2 Replit
Replit (replit.com) è una piattaforma di sviluppo online completa che ha abbracciato il vibe coding rendendolo accessibile a tutti i livelli di utenza. A differenza di Lovable, Replit è innanzitutto un IDE cloud multipurpose: permette di creare e modificare codice in una miriade di linguaggi (Python, JavaScript, C++, ecc.), eseguire applicazioni in cloud e collaborare in tempo reale con altri sviluppatori. Su questa solida base, Replit ha integrato potenti assistenti AI (come Replit Ghostwriter e il più recente Replit AI Agent) che consentono di scrivere codice tramite chat e comandi in linguaggio naturale.
Come funziona in pratica? Supponiamo di voler creare una web app con Python (Flask) e un frontend HTML/JS. In Replit si può avviare un nuovo progetto (chiamato Repl) selezionando ad esempio l’ambiente Python + Flask. A questo punto si può aprire l’AI Chat di Replit e impartire istruzioni del tipo: “Configura un progetto Flask. Crea una route ‘/’ che mostri una pagina web di benvenuto con un form di login. Dopo il login, implementa una pagina protetta che dice ‘Benvenuto, [nome]’ all’utente autenticato. Usa un dizionario in memoria per tenere username/password.” L’Agent AI di Replit comprenderà queste richieste e genererà i file di codice necessari all’interno del progetto: ad esempio un main.py con l’app Flask (comprensiva delle rotte per login e pagina protetta), un template HTML per il form di login, e così via. Replit a questo punto permette di eseguire subito l’app nell’ambiente cloud (con un click su “Run”) e fornisce un URL temporaneo dove testare la web app.
Il vantaggio di Replit è che unisce la flessibilità di un IDE tradizionale (puoi rivedere e modificare liberamente qualsiasi riga di codice generata, aggiungere librerie, accedere al terminale, ecc.) con la comodità dell’AI che scrive gran parte del codice noioso o ripetitivo. Inoltre Replit offre servizi integrati che semplificano molto passare da prototipo a app funzionante online: ad esempio un database integrato, storage per file, gestione delle secret keys e configurazioni, hosting e deploy con un singolo click. In particolare, il pulsante “Deploy” consente di prendere il tuo progetto e metterlo live su un URL pubblico senza dover configurare server, domini o container – aspetto spesso ostico per chi costruisce MVP. Replit si occupa anche di scalare automaticamente le risorse se la tua app riceve più traffico del previsto. Di fatto, Replit si propone come “la piattaforma #1 per vibe coding” in quanto copre l’intero ciclo: dall’IDE online (niente setup locale), all’AI coding assistant, fino al deploy in produzione. Questo la rende ideale per studenti, maker e startup che vogliono sperimentare idee rapidamente e iterare. Ad esempio, un team può collaborare in tempo reale sul codice generato (Replit supporta la modalità multiplayer e commenti inline per discutere parti di codice) e coinvolgere l’AI ogni volta che serve estendere una funzionalità o correggere un bug.
Python e oltre: Replit è molto popolare per progetti Python, grazie al fatto che offre ambienti pronti all’uso e che i modelli AI attuali (come GPT-4) sono particolarmente bravi a generare codice Python corretto. Questo significa che per prototipi data-driven, analisi o API veloci, poter vibe-codare in Python su Replit è un enorme acceleratore. Ad esempio, persino un veterano come Linus Torvalds ha raccontato di aver “vibe-codato” in Python uno strumento di visualizzazione per un progetto audio, lasciando fare all’AI la stesura del codice mentre lui supervisionava il risultato. Allo stesso tempo, Replit non è limitato a un linguaggio: se il tuo MVP è meglio realizzarlo come sito statico con script JavaScript, o come applicazione Node.js, o in qualsiasi altra tecnologia, l’AI di Replit potrà adeguarsi alle tue richieste (magari traducendo i prompt in un differente stack). Questa versatilità è importante perché consente di scegliere gli strumenti giusti per l’MVP senza doversi vincolare in partenza. Molti MVP web combinano un frontend (spesso HTML/CSS/JS o React) e un backend (può essere Python/Flask, Node/Express, etc.): con Replit si possono generare entrambi i lati e farli comunicare, sempre assistiti dall’AI. In sostanza Replit è uno svizzero coltellino per il vibe coding: offre un ambiente unificato dove sperimentare, prototipare e poi far evolvere il prototipo in un prodotto più robusto man mano che l’idea prende piede.
Replit può essere interpretato come un IDE cloud con esecuzione immediata, collaborazione e possibilità di deploy. In un workflow vibe coding risulta utile quando si vuole uscire dal ‘solo prompting‘ e passare a refactor, debugging e aggiunta di test sul codice generato. In pratica, Lovable massimizza la velocità ‘prompt-to-app‘, mentre Replit facilita la fase di consolidamento e manutenzione, aumentando il controllo sul progetto.
3.3 Altre soluzioni e tecnologie utili
Oltre a Lovable e Replit, vale la pena citare che il panorama dei tool AI-driven per sviluppo è in fermento. Ad esempio GitHub Copilot (basato su Codex) è stato uno dei primi assistenti ad anticipazione di codice, utile dentro VS Code o altri IDE per suggerire linee e funzioni mentre si scrive. Strumenti come Cursor o Codeium forniscono IDE con AI integrata, e servizi come Bolt, DataButton e Easycode (citate spesso nelle community) mirano a facilitare la creazione di interi progetti con l’AI. Molti di questi offrono approcci leggermente diversi – chi più low-level (aiuto nel codice riga per riga), chi più high-level (generatori di progetto interi). La scelta dello strumento dipende spesso dalle esigenze del progetto e dalle competenze di chi lo usa: per un non-programmatore assoluto, ambienti guidati come Lovable o Replit con interfacce semplificate risultano più accessibili; un utente più tecnico potrebbe preferire integrare ChatGPT o Copilot nel proprio editor tradizionale per mantenere maggiore controllo sul codice generato. Indipendentemente dallo strumento, i principi del vibe coding rimangono gli stessi: descrivere bene ciò che si vuole, procedere in modo iterativo e utilizzare l’AI come acceleratore invece che come sostituto totale dell’ingegno umano.
4. Dall’idea all’MVP: principi e scelte tecniche
L’MVP (Minimum Viable Product) non è una prima versione completa, ma un esperimento: un sistema minimo che verifica una o più ipotesi critiche con il minor costo possibile. Un errore comune è partire da una lista di feature; un approccio più robusto parte da un problem statement e da un happy path essenziale (accesso, azione principale, successo), come proposto nel workflow del webinar (Sgarbi, 2025). Dal punto di vista ingegneristico, l’MVP privilegia componenti managed (DB, auth, storage) e integrazioni standard per ridurre il tempo di implementazione e focalizzarsi su UX e valore.
Un concetto cardine nello sviluppo moderno e nelle startup è l’MVP (Minimum Viable Product): la versione minima di un prodotto che contiene solo le funzionalità essenziali per soddisfare i primi utenti e validare l’idea di business. In ottica Lean Startup, un MVP serve a massimizzare l’apprendimento con il minimo sforzo: si realizza un prototipo rapido, lo si testa sul campo raccogliendo feedback reali, e si iterano miglioramenti in base alle evidenze anziché a supposizioni.
Nel processo tradizionale, passare dall’idea all’MVP richiedeva tempo, competenze tecniche o budget per ingaggiare sviluppatori. Un team doveva definire il concept, poi trascorrere settimane (se non mesi) sviluppando un prototipo funzionante e affrontando sfide tecniche, per poi finalmente riuscire a lanciarlo e verificarne l’utilità. Con l’avvento di strumenti di AI generativa, questo percorso si è drasticamente accorciato: oggi è possibile descrivere in linguaggio naturale la propria idea a un agente AI e ottenere in pochi minuti o ore un’applicazione funzionante, da raffinare e pubblicare con pochi clic. In altre parole, il vibe coding consente a un singolo founder o piccolo team di passare “dal pensiero al prodotto” con una rapidità senza precedenti, concentrandosi sul cosa realizzare più che sul come realizzarlo.
4.1 Pianificazione dell’MVP: product thinking e scope ridotto
Anche con l’AI a disposizione, la fase iniziale di product thinking rimane cruciale. Significa chiarire cosa costruire e perché: identificare il problema da risolvere, gli utenti target e le funzionalità di base indispensabili. Prima di tuffarsi nel coding (anche se automatico), è consigliabile delineare una definition of MVP: ad esempio un Problem Statement (qual è il problema e per chi), le Core Features (le funzioni minime che dimostrano il valore centrale) e eventuali vincoli (serve un login? un database? integrazioni esterne?). Mantenere l’MVP piccolo e focalizzato è fondamentale: l’AI eccelle nel creare rapidamente prototipi di app relativamente semplici, con pochi flussi logici e schermate chiave. Se invece si tenta di costruire fin da subito un prodotto complesso, multi-utente e ricco di requisiti, si rischia di oltrepassare le capacità attuali degli strumenti AI (oltre che perdere il beneficio di velocità). Un motto utile è “fare meno, ma farlo bene”: implementare solo le caratteristiche necessarie per verificare l’idea principale sul campo.
4.2 Prototipazione rapida con l’AI
Definiti obiettivi e caratteristiche minime, entra in gioco l’AI per la prototipazione rapida. Qui il vibe coding mostra tutto il suo potenziale: invece di scrivere manualmente codice in un determinato linguaggio, lo sviluppatore si mette nei panni di un regista o product manager che comunica all’AI cosa costruire. Ad esempio, può letteralmente scrivere un prompt del tipo:
“Crea un’applicazione web per gestire una lista di attività (To-Do list). Deve permettere di aggiungere attività con un nome e una scadenza, segnare attività come completate e visualizzare l’elenco filtrando per completate/da fare. L’interfaccia sia semplice e responsive. Implementa il backend in Python (ad esempio con Flask) per salvare le attività in un piccolo database.”
Un agente AI adeguato prenderà queste istruzioni e inizierà a generare l’applicazione: creerà il codice backend (ad esempio un server Flask in Python con le rotte API per le operazioni CRUD sulle attività) e il codice frontend (HTML/CSS/JS per l’interfaccia utente) rispettando le specifiche fornite. In pochi minuti potrebbe restituire un progetto completo di file, ad esempio con una app.py contenente il server Flask e pagine web pronte all’uso.
Per concretizzare, ecco un possibile snippet di codice che l’AI potrebbe generare per la parte backend in Python (semplificato per illustrazione):
from flask import Flask, request, jsonify
app = Flask(__name__)
tasks = [] # semplice "database" in memoria
@app.route('/tasks', methods=['GET'])
def list_tasks():
return jsonify(tasks)
@app.route('/tasks', methods=['POST'])
def add_task():
data = request.get_json()
task = {"id": len(tasks)+1, "name": data["name"], "due": data["due"], "done": False}
tasks.append(task)
return jsonify(task), 201
@app.route('/tasks/<int:task_id>/complete', methods=['POST'])
def complete_task(task_id):
for task in tasks:
if task["id"] == task_id:
task["done"] = True
return jsonify({"status": "ok"})
return jsonify({"error": "Task not found"}), 404
if __name__ == "__main__":
app.run()Nell’esempio sopra, l’AI ha generato con poche istruzioni un semplice server Flask in Python con API RESTful per aggiungere attività, elencarle e marcarle come completate. Senza vibe coding, scrivere anche un progetto basico come questo avrebbe richiesto di scrivere manualmente decine di righe di codice, configurare l’ambiente, gestire errori di sintassi, ecc. Invece, descrivendo l’obiettivo in linguaggio naturale, l’AI ha prodotto uno scheletro funzionante in pochi istanti. Naturalmente il codice andrebbe poi integrato con un’interfaccia utente e testato, ma lo scopo è mostrare l’accelerazione enorme data dall’AI nella fase di prototipo. Come afferma Matt Palmer di Replit, questa metodologia consente a creatori anche non tecnici di “focalizzarsi sugli aspetti creativi dello sviluppo anziché rimanere impantanati nei dettagli tecnici”. L’AI si occupa di setup, sintassi e boilerplate, mentre l’umano può concentrarsi su idea, UX e feedback utente.
5. Strumenti davvero utili nello stack AI-driven
5.1 Stack tecnico minimo e integrazioni
Uno stack pragmatico per MVP AI-driven tende a minimizzare il ‘plumbing‘ e massimizzare la rapidità di iterazione. Un pattern ricorrente è: frontend generato e rifinito (Lovable + IDE), backend gestito con Supabase (database + autenticazione + storage), pagamenti con Stripe quando necessario e automazioni con strumenti come Make o n8n per ridurre codice di integrazione. Il criterio di scelta non è la completezza, ma la riduzione del tempo tra ipotesi e feedback.
5.2 AI per creatività, design e product execution
L’intelligenza artificiale nel contesto dello sviluppo non è utile solo a generare codice: può essere un prezioso alleato in tutte le fasi, dalla concezione creativa al design dell’interfaccia, fino all’esecuzione tecnica e al delivery del prodotto. Vediamo come:
Creatività e brainstorming: gli stessi modelli linguistici che scrivono codice possono aiutare a generare idee. Ad esempio, ChatGPT può essere interpellato nelle prime fasi di un progetto per fare brainstorming su funzionalità possibili, trovare soluzioni alternative a un problema di design, o persino proporre nomi e slogan per il prodotto. Si può chiedere all’AI “come potrei risolvere il problema X con la tecnologia?” oppure “quali caratteristiche vorrebbero gli utenti in un’app di tipo Y?”. L’AI, attingendo al suo addestramento su miliardi di documenti, può suggerire spunti che il team umano non aveva considerato. Chiaramente non ogni output sarà valido, ma anche solo stimolare la discussione attraverso suggerimenti creativi è un valore. Molte startup sfruttano GPT-4 come collaboratore virtuale nelle sessioni iniziali di product thinking, per ampliare lo spazio delle idee.
Design dell’esperienza utente (UX/UI): oggi esistono AI specializzate che generano layout grafici o schizzi di interfaccia da descrizioni (es. “uno schermo di login con email e password e un pulsante rosso di submit”). Strumenti come Galileo AI, Uizard, o lo stesso Replit Design (introdotto recentemente) trasformano prompt testuali in bozze di interfacce. Questo significa che un progettista può rapidamente esplorare varianti di design senza dover disegnarle a mano da zero. Anche senza tool dedicati, i modelli generici possono produrre codice HTML/CSS per prototipi di interfaccia: ad esempio ChatGPT può scrivere il codice di una navbar o di un form ben formattato se richiesto. Ciò accelera la fase di prototipazione UI, permettendo di avere qualcosa di cliccabile per test utente in tempi brevi. Inoltre l’AI può generare contenuti di placeholder: testi fittizi, immagini (tramite modelli generativi tipo DALL-E o Midjourney) per rendere il prototipo più realistico. Sul fronte UX, l’AI può fornire feedback simulando l’utente: ad esempio si può chiedere “questo flusso di registrazione è chiaro?” e ottenere suggerimenti (anche se qui l’occhio umano esperto rimane insostituibile). In sostanza, se usata bene, l’AI diventa una cassetta degli attrezzi creativa per designer e product manager.
Esecuzione tecnica e sviluppo: questo è l’ambito già esplorato con il vibe coding. L’AI può accelerare enormemente la fase di implementazione: generazione di codice backend, configurazione di database, scrittura di test automatici, creazione di API client, documentazione del codice, ecc. Ad esempio, una volta sviluppato l’MVP, si può chiedere all’AI di produrre una serie di test unitari per assicurarsi che le funzioni critiche funzionino (molti hanno sperimentato con successo prompt come “scrivi i test per questa funzione in PyTest”). Oppure, può aiutare nella migrazione del codice: se il prototipo cresce e serve passare da un database in memoria a uno persistente, l’AI può fornire lo schema di come integrare un database SQL o NoSQL, scrivendo le query o configurando ORM. Durante lo sviluppo, l’AI funge anche da assistente di debugging: se un errore non è chiaro, si può incollare lo stack trace nel prompt e chiedere spiegazioni o possibili fix. Un aspetto importante è anche l’ottimizzazione: magari l’MVP funziona ma è lento; l’AI può suggerire come migliorare le prestazioni (ad esempio, “questo algoritmo ha complessità O(n^2), potresti usare un approccio più efficiente come…”). Insomma, l’AI può essere vista come un collega virtuale sempre disponibile, con una vasta conoscenza, che aiuta a scrivere codice, trovare bug, proporre miglioramenti e ricordare sintassi e best practice all’istante. Sfruttata a pieno, può ridurre drasticamente i colli di bottiglia nello sviluppo esecutivo di un prodotto.
Da notare che queste capacità dell’AI non eliminano la necessità di competenza umana, ma ne aumentano il raggio d’azione. Un piccolo team può produrre risultati da grande team, perché delega alla “forza lavoro” artificiale i compiti ripetitivi o di dettaglio, mantenendo però il controllo creativo e decisionale. In ambito universitario, per esempio, uno studente può concentrare il proprio apprendimento sui concetti di alto livello (es. logica algoritmica, architettura del software) sapendo che l’AI lo aiuterà con la scrittura effettiva del codice sintatticamente corretto. Questo suggerisce un futuro in cui meno tempo è speso a scrivere codice boilerplate, e più tempo a progettare soluzioni, che è il cuore creativo dell’informatica.
6. Best practice ed errori comuni da evitare
Nel vibe coding gli errori più costosi sono spesso di processo: partire senza un problema chiaro, delegare la strategia all’AI, trascurare UX e micro-copy, iterare troppo poco (prototipo fragile) o troppo (perfezionismo). Il webinar evidenzia che definire bene il problema vale ‘meta’ del lavoro e che la velocità dell’iterazione supera l’illusione del planning perfetto (Sgarbi, 2025).
Nonostante le promesse, il vibe coding nasconde anche diverse trappole se praticato ingenuamente. Di seguito alcune best practice consigliate e gli errori da evitare, emersi sia dall’esperienza degli utenti sia dai pareri di esperti:
Prompt precisi e modulari: un errore comune è dare all’AI richieste vaghe o troppo generali (“fai un’app tipo Uber”). Prompt così aperti portano l’AI a fraintendere o a produrre risultati incompleti. Conviene invece specificare chiaramente ciò che si vuole ottenere, suddividendo il lavoro in passi. Una regola pratica: un task alla volta. Ad esempio, prima chiedere di creare la schermata di login, poi in un secondo prompt aggiungere la funzionalità di reset password, e così via. Questo aiuta sia l’AI (che ha limiti di contesto e tende a confondersi con troppi requisiti insieme) sia voi a controllare meglio ogni componente man mano che viene costruita.
Versionare e salvare spesso: quando si procede per iterazioni con l’AI, può capitare che un cambiamento richiesto rompa parti funzionanti in precedenza. È buona pratica usare un sistema di version control (ad esempio Git, o anche le snapshot integrate in Lovable/Replit) per creare checkpoint del progetto. In caso di “deragliamento” del codice generato, si può tornare a una versione stabile precedente. Alcuni sviluppatori in vibe coding adottano la filosofia “revert fearlessly”: se l’AI introduce un errore architetturale grave, conviene annullare l’ultima modifica e provare una strada diversa, invece di intestardirsi a far correggere al bot qualcosa che potrebbe non aver compreso.
Verificare e testare sempre (Trust but verify): il vibe coding puro implica accettare il codice generato senza comprenderlo a fondo, ma ciò non esime dal testarlo rigorosamente. Ogni funzionalità generata va provata con vari input per assicurarsi che si comporti come previsto. Se non si hanno test automatici, fatene almeno di manuali. In particolare, attenzione a corner cases: l’AI può non prevedere situazioni non esplicitamente descritte nel prompt. Inoltre, leggere almeno superficialmente il codice prodotto – se si hanno competenze per farlo – può aiutare a intercettare assurdità logiche o cose che l’AI ha “hallucinato”. Un principio condiviso è: non fidarsi ciecamente. Come nota un programmatore, “non mi fido di nulla di quello che mi dice l’AI finché non l’ho verificato”. Questo è doppiamente vero per il codice che va in produzione.
Occhio a sicurezza e qualità: l’AI genera codice attingendo da ciò che ha imparato, il che include anche esempi di codice insicuro o obsoleto. Di conseguenza, c’è il rischio che introduca vulnerabilità note (injection, errori di convalida input, dipendenze insicure) se il prompt non specifica contromisure. Evitare gli errori di sicurezza più comuni deve essere una priorità: ad esempio, verificare che l’AI abbia gestito correttamente la sanitizzazione degli input utente, l’autenticazione, la protezione delle API key, ecc. Se non l’ha fatto, intervenite manualmente o istruitela a farlo. Un’azienda non dovrebbe mai accettare codice AI tal quale senza passarlo per i consueti controlli di qualità (code review, audit di sicurezza, test). Inoltre, la mancanza di trasparenza nei cambiamenti introdotti dall’AI può complicare la tracciabilità: in un progetto open source si può vedere la cronologia delle modifiche e chi le ha fatte; con il codice generato dall’AI, questa storia manca. È opportuno dunque documentare quello che si fa generare (es. mantenere commenti che indichino “funzione X generata con prompt Y”) e magari conservare i prompt usati, per future analisi.
Non trascurare l’apprendimento personale: un errore soprattutto per chi è agli inizi è adagiare troppo le proprie competenze sull’AI. Se uno studente o junior developer delega sempre all’AI senza cercare di capire il perché delle soluzioni, rischia di bloccare la propria crescita. Come evidenziato in ambito educativo, l’AI va usata come assistente, non come sostituto. Continuate a studiare le basi: algoritmi, strutture dati, paradigmi di design. Il vibe coding può dare l’illusione di non dover più “imparare a programmare” in senso tradizionale, ma in realtà per usare bene questi strumenti serve più comprensione logica e analitica, non meno. Bisogna bilanciare l’utilizzo dell’AI con la pratica manuale, per non incorrere in un offload cognitivo totale in cui poi, senza AI, non si sa fare nulla. Un buon metodo è sfruttare l’AI in modalità interattiva: farle spiegare il codice che ha scritto (“perché hai usato questa funzione?”), chiedere alternative, insomma usarla anche come strumento didattico. Così si rimane in controllo e si trasforma una potenziale pigrizia in opportunità di apprendimento accelerato.
Gestire costi e risorse: molte piattaforme AI (Lovable, ma anche le API di OpenAI usate in Replit) funzionano a consumo, con crediti o quote mensili. Fate attenzione a non sprecare risorse in prompt ridondanti o cicli infiniti. Se l’AI rimane bloccata su un problema dopo vari tentativi, forse conviene fermarsi e ridurre il problema in parti più piccole o consultare un umano esperto. Inoltre, quando il codice cresce, l’AI potrebbe non reggere tutto il contesto in una singola richiesta (limiti di token): in questi casi bisogna adattare la strategia, ad esempio fornendo riassunti del codice o lavorando su moduli separati. Pianificare minimamente l’architettura prima di gettare l’AI sulla tastiera può farvi risparmiare soldi e tempo nel lungo periodo.
In definitiva, evitare questi errori significa usare il vibe coding in modo consapevole e professionale: beneficiando della velocità e creatività che l’AI offre, ma allo stesso tempo mitigando i rischi con disciplina ingegneristica classica. Un buon developer che adotta l’AI rimane critico verso il risultato, effettua test, e sa quando rientrare in controllo manuale del codice.
7. Sicurezza nel rapid development: prevenzione prima di tutto
Le applicazioni nate in contesti rapidi e sperimentali finiscono spesso online molto presto: ciò rende i rischi concreti, anche quando il progetto nasce come semplice MVP. Nel documento ‘Security in Lovable: Prevenzione Prima di Tutto‘ viene evidenziato che la sicurezza non è sempre ‘visibile‘ durante lo sviluppo, e che serve un meccanismo continuo di prevenzione. La domanda guida proposta è: ‘Se questa applicazione fosse pubblicata oggi, cosa potrebbe vedere chiunque da Internet?’. L’obiettivo non è sostituire un audit professionale, ma prevenire errori comuni dovuti a fretta e configurazioni lasciate di default (Lovable.dev, n.d.).
8. Workflow reale: Product Thinking + Rapid Prototyping + AI-driven Development
8.1 Scenario di esempio: Proposal Assistant per freelance
Per illustrare un flusso di lavoro concreto che unisce product thinking, prototipazione rapida e AI-driven development, consideriamo un esempio pratico:
Scenario: immaginiamo che una studentessa di informatica abbia un’idea di startup: un’app mobile/web che aiuta i freelancer a generare proposte di progetto automaticamente, rispondendo a qualche domanda chiave. L’obiettivo è creare rapidamente un MVP per testare l’interesse dei primi utenti.
Ideazione e Product Thinking: la studentessa definisce il problema: “i freelancer perdono molto tempo a scrivere proposte; un assistente AI potrebbe generarne una bozza in base a input standard (descrizione progetto, budget, durata, ecc.)”. Identifica come utenti target i freelance junior o con poco tempo. Definisce le core features dell’MVP: una semplice interfaccia web con un form di input (domande sulle esigenze del progetto) e un output testuale generato dall’AI (la proposta da usare come base). Come vincolo decide che non servirà autenticazione utente nella prima versione, per ridurre la complessità: l’MVP sarà single-user, ognuno genera la sua proposta e la copia.
Progettazione rapida (bozza): prima di codificare, pensa al flusso utente: una pagina iniziale di benvenuto con un pulsante “Inizia”; una pagina di questionario con campi (nome cliente, descrizione progetto, tempistiche…); un bottone “Genera Proposta” che scatena la chiamata all’AI; infine una pagina di risultato con il testo della proposta e un pulsante per copiarla. Questo schema a 3 schermate è annotato su carta o su una lavagna, giusto per avere chiaro il percorso.
Implementazione con vibe coding: ora passa agli strumenti AI. Decide di provare prima Lovable per costruire velocemente il front-end e la logica AI. Su Lovable, crea un nuovo progetto e nel prompt iniziale descrive: “App generatore di proposte per freelance. Pagina 1: benvenuto con pulsante Start. Pagina 2: form con domande (nome cliente, descrizione progetto, budget, durata) e bottone ‘Genera Proposta’. Quando cliccato, l’AI deve prendere le risposte e generare un testo di proposta che includa quei dati in tono formale professionale. Pagina 3: mostra la proposta generata e un pulsante ‘Copia testo’. Usa uno stile semplice e intuitivo.” Dopo qualche decina di secondi, Lovable restituisce un’app pronta: dietro le quinte ha creato le schermate con i relativi UI blocks (titoli, campi di input, pulsanti) e definito la logica in linguaggio naturale per assemblare le risposte e chiamare un modello di linguaggio (ad esempio l’API di OpenAI) per generare il testo della proposta. La studentessa può entrare in modalità preview e testare l’app inserendo dati fittizi, verificando se l’output ha senso. Supponiamo che la prima versione generi una proposta troppo breve; lei allora aggiorna il prompt interno della logica su Lovable, aggiungendo ad esempio “il testo finale dovrebbe avere almeno 4 paragrafi dettagliati”. Ritesta e ottiene un risultato migliore. In meno di un’ora, ha un prototipo funzionante del suo servizio.
Collegamento di componenti custom: ora, poniamo che il modello di Lovable per generare il testo non le piaccia (magari vuole usare un proprio modello open-source ospitato altrove, o aggiungere un controllo sui dati). Qui entra la flessibilità di integrare codice Python custom se necessario. La studentessa crea su Replit un piccolo servizio Flask con un endpoint /genera_proposta che riceve in JSON i dati del form e restituisce un testo generato da un suo script Python (potrebbe usare una libreria locale o un modello HuggingFace per generare il testo). Utilizzando vibe coding anche qui, descrive in Replit cosa deve fare questo endpoint e lascia che l’AI prepari il codice Python corrispondente, che poi adatta alle sue esigenze. Una volta soddisfatta, deploia l’API Python con Replit (ottenendo ad es. un URL pubblico tipo https://nomeprogetto–utente.repl.co/genera_proposta). Torna in Lovable e configura nella schermata di generazione proposta un API Call Block verso questo nuovo endpoint. In questo modo combina i punti di forza di entrambi gli strumenti: Lovable per l’interfaccia e la struttura dell’app, Replit per logica custom aggiuntiva in Python. In generale, è possibile unire servizi – il bello dei moderni approcci cloud.
Test e iterazione: con il prototipo pronto, lo condivide con alcuni freelance conoscenti per ottenere feedback. Grazie alla velocità con cui è stato creato, può permettersi di iterare rapidamente: se i tester dicono che manca una certa sezione nella proposta, o che l’output è troppo generico, basta tornare nell’AI e affinare i prompt o aggiungere quel campo. La fase di debugging è supportata dagli strumenti stessi: Lovable ad esempio ha un pannello debug per vedere i valori delle variabili attraverso le schermate e monitorare il flusso, mentre su Replit può usare i log del server Flask per capire eventuali errori. In pochi cicli la qualità del prototipo migliora sensibilmente.
Rilascio dell’MVP: una volta soddisfatta, può rilasciare l’MVP al pubblico target. Lovable permette di pubblicare l’app (fornendo un link web utilizzabile dai client) e Replit ha già il suo servizio live. Costi e tempi di tutto questo? Forse qualche decina di dollari in crediti AI e pochi giorni di lavoro – contro le settimane e migliaia di dollari che avrebbe richiesto sviluppare front-end, back-end e modelli AI manualmente con un team tradizionale. Questo esempio mostra come un workflow integrato che combina pensiero di prodotto (focus su problema e utente), prototipazione rapida (implementazione immediata via AI), e sviluppo guidato dall’AI (iterazioni rapide sul codice) possa concretizzare un’idea in un MVP tangibile prontamente testabile sul mercato.
Un workflow efficace unisce product thinking e AI-assisted coding in cinque fasi: (1) problem statement, (2) definizione dell’happy path, (3) initial prompt ricco di vincoli, (4) iteration cycle basato su gap e fix mirati, (5) refine & deploy con rifinitura UI/UX e copy. Questo schema corrisponde al flusso presentato nel webinar (Sgarbi, 2025) e riduce drasticamente il tempo tra idea e validazione.
8.2 Prompt template (esempio)
Esempio di prompt iniziale per avviare un MVP in Lovable:
Crea una web app full-stack chiamata “MakerShop”.
Target: artigiani che vogliono vendere online senza competenze tecniche.
Schermi richiesti:
1) Landing con CTA “Crea il tuo shop”
2) Signup/Login (email + password)
3) Wizard in 3 step: nome shop, logo, categoria
4) Dashboard: lista prodotti (CRUD), anteprima shop pubblico
5) Pagina pubblica dello shop con prodotti e pulsante “Acquista”
Vincoli:
– UI pulita, mobile-first, italiano, micro-copy chiaro
– Validazioni form (email, campi obbligatori) con messaggi amichevoli
– Backend dati su Supabase (utenti, shop, prodotti)
– Deploy con URL condivisibile
9. Caso studio 1: MakerShop (MVP e-commerce AI-first)
Il primo caso studio riprende lo scenario illustrato nel webinar (hackathon): costruire un MVP in poche ore per validare una piattaforma e-commerce orientata ai maker, in cui la creazione del negozio avviene tramite chat AI. Il valore dell’MVP è verificare rapidamente due ipotesi: (a) i maker vogliono vendere, (b) la barriera tecnica è un blocco significativo. Il progetto può essere implementato con: UI generata in Lovable, dati e autenticazione su Supabase e successiva rifinitura del codice (ad esempio su Replit) per autorizzazioni e validazioni.
9.1 Esempi di implementazione: validazione e autorizzazione
Validazione email con messaggio user-friendly (da rifinire spesso manualmente):
export function validateEmail(email: string): string | null {
const e = email.trim();
if (!e) return "Inserisci un indirizzo email.";
const re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
if (!re.test(e)) return "L’email non sembra valida. Controlla e riprova.";
return null;
}Isolamento dati per utente (pattern minimo di autorizzazione in un CRUD):
const { data, error } = await supabase
.from("products")
.select("*")
.eq("owner_id", user.id);10. Caso studio 2: Dashboard interna e CRUD ‘enterprise-light‘
Un secondo scenario tipico, spesso ‘luce verde‘ per vibe coding, è una dashboard interna che aggrega dati da un database esistente e offre funzionalità CRUD per processi operativi (ticket, asset, richieste, inventario). Rispetto a un prodotto consumer, l’obiettivo principale è ridurre tempi di lavoro e migliorare visibilità su KPI, non massimizzare conversion. In questo contesto, il vibe coding accelera la costruzione del front-end, la definizione delle viste e la connessione al backend, mentre Replit/IDE risulta utile per introdurre controlli di accesso per ruoli, logica di validazione e test.
10.1 Requisiti minimi del prototipo
Requisiti essenziali per una dashboard interna: (a) autenticazione e gestione ruoli (admin, operator), (b) viste KPI (es. ticket aperti/chiusi, SLA, backlog per categoria), (c) CRUD su entità principali (ticket, utenti, asset), (d) esportazione CSV e audit log minimo. Questi requisiti permettono di validare rapidamente benefici e adozione senza costruire un sistema completo.
10.2 Esempio pratico: endpoint KPI e consumo lato UI
Esempio minimale (Node/Express) di endpoint KPI, utile quando si esce dal low-code puro:
import express from "express";
import { createClient } from "@supabase/supabase-js";
const app = express();
const supabase = createClient(process.env.SUPABASE_URL!, process.env.SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY!);
app.get("/api/kpi/tickets", async (req, res) => {
// Nota: in produzione aggiungere auth e controlli di ruolo (RBAC)
const { data, error } = await supabase
.from("tickets")
.select("status", { count: "exact", head: false });
if (error) return res.status(500).json({ error: error.message });
const total = data?.length ?? 0;
const open = data?.filter(t => t.status === "open").length ?? 0;
const closed = data?.filter(t => t.status === "closed").length ?? 0;
res.json({ total, open, closed });
});
app.listen(3000);
Esempio React di consumo dati KPI:
async function loadKpi() {
const r = await fetch("/api/kpi/tickets");
if (!r.ok) throw new Error("Errore nel caricamento KPI");
return r.json();
}11. Metodologia sperimentale: metriche e validazione
Per valutare in modo ripetibile l’efficacia del vibe coding rispetto a uno sviluppo tradizionale (o rispetto a baseline interne), è utile definire una metodologia sperimentale con metriche e criteri di successo. Qui si propone un disegno sperimentale leggero, adatto a contesti universitari e prototipi reali.
11.1 Disegno sperimentale
Si definiscono due condizioni: A) sviluppo AI-driven (Lovable + Replit/IDE), B) sviluppo tradizionale (IDE + framework standard, senza generazione UI/logica). Entrambe implementano lo stesso set di requisiti minimi per un MVP, con tempi e risorse comparabili. Si raccolgono metriche su tempo, qualità, usabilità e outcome di validazione.
11.2 Metriche di tempo
Tempo-to-first-prototype (TtP): minuti/ore dal problem statement a una versione navigabile. Tempo-to-MVP (TtM): tempo fino a deploy condivisibile con happy path completo. Iteration count: numero di cicli prompt-test-fix fino a stabilità percepita.
11.3 Metriche di qualità e bug rate
Bug rate: numero di difetti per ora di test o per sessione utente, classificati per severità (bloccante, alto, medio, basso). Regression rate: difetti introdotti da una modifica successiva. Stabilità build: percentuale di deploy senza errori critici. Per ridurre bias, i bug possono essere raccolti con un test script comune e una checklist.
11.4 Metriche di usabilità
Usability: valutazione con questionario SUS (System Usability Scale) o con metriche operative (tempo medio per completare il task, errori per task). Task success rate: percentuale utenti che completano l’happy path senza assistenza. Qualità percepita: rating qualitativo su chiarezza dei messaggi, coerenza UI e fiducia.
11.5 Metriche di conversion e validazione prodotto
Activation rate: percentuale utenti che completano un’azione chiave (es. creazione shop, creazione primo ticket). Retention breve: utenti che tornano entro 7 giorni (se applicabile). Conversion (se monetizzazione): percentuale utenti che avviano checkout o attivano un piano. In contesti interni, conversion può essere sostituita da metriche di adozione (utenti attivi settimanali) e risparmio tempo.
11.6 Raccolta dati e strumentazione
La raccolta dati può essere ottenuta con: logging eventi (es. ‘signup_completed’, ‘first_item_created’), tracciamento errori (client e server), e un semplice dashboard di analytics. È fondamentale rispettare principi minimi di privacy: minimizzare i dati raccolti e evitare logging di informazioni sensibili.
12. Dal prototipo alla produzione: transizione e scalabilità
Il vibe coding è particolarmente efficace prima della piena comprensione del problema; quando l’idea è validata e si ottiene trazione, diventa strategico consolidare con pratiche ingegneristiche standard: test, CI/CD, hardening di sicurezza, refactor architetturale e osservabilità. Nel webinar viene sottolineato che la transizione è spesso ‘liscia’ perché il codice generato tende a essere basato su stack standard, e quindi evolvibile senza buttare via lavoro (Sgarbi, 2025).
Conclusioni
Il vibe coding è un acceleratore potente per prototipi e MVP quando è guidato da product thinking chiaro e da iterazioni rapide. Lovable riduce drasticamente il tempo di generazione e deploy, mentre Replit/IDE supporta il consolidamento con refactor e test. La velocità, tuttavia, amplifica errori di processo e rischi di sicurezza: per questo è utile adottare un approccio di prevenzione continua e verifiche esplicite di esposizione dati prima di condividere un URL. Con una metodologia sperimentale basata su metriche, è possibile misurare in modo oggettivo benefici e limiti dell’approccio AI-driven in contesti universitari e professionali.
Il vibe coding rappresenta senza dubbio una svolta nel modo di sviluppare software, spingendo verso uno scenario in cui “tutti possono programmare” in qualche misura grazie all’AI. In un contesto universitario, questa tecnologia offre spunti sia pratici che teorici: pratici perché gli studenti possono realizzare progetti più ambiziosi in meno tempo (e le piccole imprese prototipare soluzioni innovative con costi ridotti), teorici perché solleva nuove sfide su come garantire qualità, sicurezza e formazione delle competenze in un’era di automazione del codice. Abbiamo visto come strumenti come Lovable e Replit incarnino questa filosofia fornendo piattaforme per produrre MVP funzionanti in giorni invece che mesi. Allo stesso tempo, l’adozione diffusa del vibe coding nel mondo reale sta evidenziando l’importanza di procedure di validazione: i team devono adattare i propri workflow (ciclo di vita del software, controlli di versione, auditing) per integrare in modo sicuro ed efficace codice generato dall’AI.
In prospettiva futura, il ruolo del developer potrebbe sempre più somigliare a quello di un direttore d’orchestra, in cui l’AI suona molti degli strumenti tecnici. Ma la melodia – l’idea, la soluzione creativa al problema – deve ancora provenire dall’ingegno umano. Come per ogni salto tecnologico, vincerà chi saprà trovare il giusto equilibrio: sfruttare appieno i vantaggi dell’AI (produttività, rapidità, accesso democratico alla programmazione) senza sacrificare la solidità del prodotto e la crescita delle competenze fondamentali. In conclusione, il vibe coding non sostituisce la buona progettazione, ma la potenzia: permette di passare “dal foglio bianco all’app” con facilità, richiedendo però al progettista di mantenere visione lucida, spirito critico e cura per i dettagli. Queste qualità, unite agli strumenti AI-driven, possono aprire la strada a una nuova generazione di sviluppatori in grado di trasformare idee in realtà a una velocità prima impensabile.
Bibliografia
Sgarbi, E. (2025). AI-Driven Product Creation: Workflow reale per founder, developer e innovatori. Slide/webinar (PDF allegato).
Lovable.dev (n.d.). Security in Lovable: Prevenzione Prima di Tutto. Slide deck (PDF allegato).
Ries, E. (2011). The Lean Startup. Crown Business.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Wiley.
Brooks, F. P. (1975). The Mythical Man-Month. Addison-Wesley.
Karpathy, A. (2025, Feb). “There’s a new kind of coding I call vibe coding…” Post su X/Twitter.
Replit Blog. (2025, Mar). “What is Vibe Coding?”.
IBM Blog. (2025). “What is vibe coding?”.
Wired Italia. (2025, Ott). Articolo sui rischi del vibe coding (sicurezza e supply chain).
Tom’s Hardware Italia. (2026, Gen). Articolo su vantaggi/opportunità del vibe coding.
Lundahl, M. (2025, Apr). “Lovable.dev Review: Great for MVPs…”.
Mobitouch. (2025). “How to build an MVP with AI (Lovable)”.
Wikipedia. (consultata 2026). Voce “Vibe coding” (edizioni en/it).